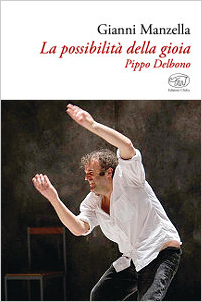-
Sulla soglia fra presente e passato. Pupo di zucchero di Emma Dante
Non c’è nulla di nuovo in questo Pupo di zucchero, nulla che non conosciamo già del teatro di Emma Dante. Possiamo dirlo diversamente: tutto il teatro di Emma Dante è concentrato nell’arco di un’ora in questo commovente Pupo di zucchero, presentato l’anno scorso a Spoleto e ora in giro speriamo a lungo, a Roma ha inaugurato la stagione del teatro Argentina. Tutto comincia nel buio, per l’artista siciliana, lo sappiamo. C’è quello spazio buio, da cui non è possibile uscire, che per lei è la scena come equivalente della scatola cranica, lì dove tutto avviene. C’è la famiglia o forse i suoi fantasmi, e anche da lì non si può uscire facilmente. C’è soprattutto il convivere dei vivi con i morti, che quei fantasmi fanno rivivere in una lotta con il tempo perduta in partenza ma proprio per questo tanto più commovente. Dove insomma i Ballarini della Trilogia degli occhiali incontrano le Sorelle Macaluso.
Qui il vivo è uno solo, ma chi può giurarci – credete che io sia viva? chiedeva già la Sgricia dei Giganti pirandelliani. È sottile la soglia fra i morti e i vivi. Nell’occasione Emma Dante ha preso lo spunto da uno dei cunti di Giambattista Basile, poco più di una suggestione però, per consegnare alla lingua napoletana del protagonista Carmine Maringola e agli altri attori della compagnia Sud Costa Occidentale una di quelle sue storie un po’ nere, un po’ crudeli, un po’ derisorie, che tengono a bada il pathos per non cadere nel patetico, senza concedere mai la consolazione della catarsi. Avere ricordi non basta, dice Emma Dante con Rainer Maria Rilke. Devono diventare sangue, sguardo e gesto.

Foto di Ivan Nocera
All’inizio il vecchio se ne sta seduto davanti a un panchetto, a mormorare il suo solitario rosario. Ogni tanto la testa gli cade da un lato, presa in un invincibile sonno. Sul panchetto sta disteso un panno con sopra un impasto di acqua e farina ancora informe. È il due novembre, il giorno dei morti, quando la tradizione vuole che si preparino dolcetti per i defunti. Altrove si chiamano ad esempio fave dei morti, in Sicilia sono i “pupi ri zuccaro” del titolo e infatti l’uomo ha preparato per l’occasione quell’impasto che però stenta a lievitare, in attesa di sposarsi a mandorle e zucchero e acqua di rose. Per convocare accanto a sé tutta una famiglia che non c’è più, è rimasto solo nella grande casa vuota. Non soltanto le giovani figure femminili che stanno in piedi alle sue spalle, le tre sorelle che hanno nomi di fiori e cercano di ridestarlo suonando un campanellino al di sopra della sua testa.
Quando una di loro comincia a cantare l’ottocentesca Luna nova di Salvatore Di Giacomo e Mario Costa tutto sembra animarsi attorno a lui. La luna nova ’ncopp’a lu mare, stènne na fascia d’argiento fino. Marinaio era il padre, sempre in giro per mare finché un giorno non era più tornato, e mammina venuta chissà come da Marsiglia andava tutti i giorni sul molo ad aspettarlo. Ed eccoli tutti lì a far festa. Lo spagnolo Pedro, parente acquisito sempre puntuale all’ora di pranzo. La zia Rita che con la tetta scoperta cerca di tener buono il suo uomo violento, ma sono sempre sesso e botte. Questo non è amore, dice il vecchio. E poi il ragazzo Pasqualino dalla pelle nera e l’anima giocosa, portato dal mare per una sorta di compensazione o di risarcimento e cresciuto come un figlio. E lui, il vecchio, che dimentico del cuore tremmolante salta insieme a quel giovane padre che porta un fiore all’occhiello, tanto somigliante a quello delle ragazze Macaluso, col pettinino in tasca e la piroetta pronta. A un certo punto provano anche ad arredarlo quello spazio vuoto, al centro il letto e attorno la poltrona e la tavola nel vuoto nero dipinto di nero. Da sotto una coperta fiorata emergono in sottoveste e con una cuffietta in testa le tre sorelle, rimaste fissate nella giovinezza di quando la morte le aveva colte, tutte insieme. Finché si ritrovano tutti riuniti a formare un gruppo di famiglia pronto per la fotografia.

C’è l’evidente impronta di Tadeusz Kantor e del suo finale “teatro della morte” in questa immagine, e non solo, non tanto per quei manichini, opera di Cesare Inzerillo, in cui si duplicano nel finale le figure di questo album familiare. C’è di mezzo l’idea della memoria come polveroso magazzino, abitato da personaggi non sempre rispettabili che non smettono di buttarci in faccia la loro vita. Ma bisogna intendersi, sulla declinazione che ne offre Emma Dante. Che può aiutare a rileggere anche il maestro polacco. Giacché questa memoria degradata non è tuttavia statica, e questi defunti non possono sottrarsi alla sorte umana di evolversi, se pure di una evoluzione postuma si tratta. Avere ricordi non basta, se è messa in questione la loro identità. L’ossessione del ricordo si smorza sulla soglia fra passato e presente. O forse è invece tutto un andare avanti e indietro fra presente e passato, per sottrarsi alla coscienza dell’oblio come unica certezza che riserva il futuro.
Ed ecco che madre e padre si liberano degli abiti consumati dal tempo, cioè dei loro anni, e tornati ragazzi vestiti di lamé si lanciano in un ballo sempre più scatenato, nelle luci fluo di una balera dove tutti convergono, richiamati in quel passato. E si fatica a non cedere alla commozione, presi nella trappola di quel singolare veicolo di trasporto delle emozioni che è la musica. Che ci proietta nel passato, cioè ognuno nel proprio passato, volti gesti parole. E ballando è tutta una vita che scorre a ritroso, risalendo il tempo controcorrente, come i Ballarini di qualche anno fa, e forse in un prossimo Tango delle capinere.

Raggiunto quell’acme emotiva, l’azione lentamente decanta, in un precipitato di azioni dove tutto sembra ripetersi. Ma già un poco mutato. Le botte alla zia Rita sono diventate un feroce pestaggio. Questo non è amore, continua a ripetere lui. Intorno al tavolo su cui l’impasto non vuole saperne di lievitare, può scatenarsi la clownerie. Ma la festa dei morti volge al termine. Il pupo di zucchero è completato. Ecco che tornano tutti, trascinando in una danza macabra i propri mummificati doppi, per poi appenderli in fila, uno accanto all’altro, a un’intelaiatura metallica che sembra formare altrettanti loculi ai lati di una croce. L’immagine non lascia dubbi, nel richiamo alle catacombe dei Cappuccini che stanno a Palermo. Dove se no? Che fai, corteggi la morte? chiedeva Tancredi allo zione Principe di Salina, fermo in contemplazione davanti a un funereo dipinto di Jean-Baptiste Greuze, ma forse attratto più dal disordine delle vesti delle ragazze – graziose, procaci, osserva. Il vecchio ha acceso ai piedi delle mummie tanti lumini rossi. La cerimonia è terminata. Lui ha ricominciato con il suo rosario. Già la testa gli cade da un lato, nel sonno. Nel buio resta solo la pallida fiamma dei lumini rossi.
© Gianni Manzella
Articoli correlati