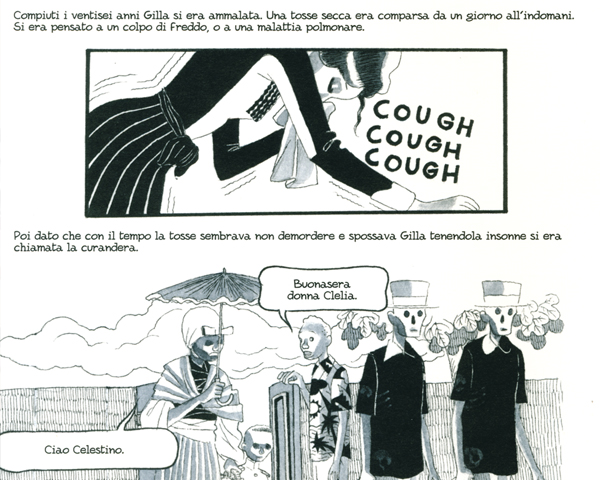-
Da Slumberland al Parador: conversazione con Igort
Igort, nome d’arte di Igor Tuveri. Scrive e disegna storie a fumetti dal 1979 su testate italiane e straniere (Alter, Linus, Frigidaire, Echo des Savanes, Metal Hurlant, Comic Morning, The Face). Ha fondato nel 1982 con Lorenzo Mattotti e altri autori Valvoline, un gruppo di ricerca teso a espandere le potenzialità del linguaggio del fumetto. I suoi lavori sono pubblicati in una quindicina di paesi e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui nel 2003 il premio come miglior libro dell’anno al Festival di Francoforte con 5 è il numero perfetto. Ha collaborato con Ryuychi Sakamoto e con Kodansha, la casa editrice del nuovo manga. Ha fondato nel 2000 Coconino Press, una casa editrice specializzata in romanzi grafici, che pubblica in Italia, Francia e America. Ha esposto alla Biennale di Venezia del 1994 e in altre mostre personali e collettive. Ha al suo attivo una carriera di musicista (Slava trudu, Maccaroni Circus) e ha inciso diversi album. È autore e conduttore radiofonico (Popolare network e Radio2 Rai). Vive e lavora a Parigi.
È da poco terminata a Bologna presso la Galleria Ta Matete un’ampia retrospettiva dedicata al tuo lavoro. 5 è il numero perfetto, pubblicato nel 2002 da Coconino Press, nel mese di dicembre è uscito con Repubblica, all’interno della collana realizzata in collaborazione con Coconino Press e dedicata alla graphic novel. Puoi tracciare un bilancio, per così dire, a metà del cammino, del tuo percorso di ricerca?
Credo che il romanzo grafico stia uscendo dalle biblioteche dei suoi cultori per giungere finalmente ai lettori. Pubblicare con i grandi editori aiuta certo, ma non è fondamentale per costruire buoni romanzi. Anzi probabilmente le pressioni di mercato soffocano o disturbano le idee nuove o originali. Io mi reputo fortunato, pubblico le mie storie da quasi trent’anni e sono una persona piuttosto ostinata. Mi piace seguire una strada che mi fa stare bene. Per questo ho assoluto bisogno di sentirmi a mio agio e di subire pochi condizionamenti.
Dagli esordi su “Frigidaire” e dalle prime esperienze editoriali – mi riferisco a “Dolce Vita” e al gruppo Valvoline – a oggi, cos’è cambiato secondo te nella percezione del fumetto? Il fatto che il Gruppo editoriale L’Espresso abbia intrapreso un’impegnativa operazione di divulgazione – prima con la pubblicazione dei classici, ora con i romanzi grafici – è un segnale che esiste una domanda di fumetto di qualità che va oltre la nicchia di appassionati?
Si tratta di comprendere che esiste un progetto esistenziale nella testa di pochi sognatori. Il resto sono semplici businessmen che si occupano di editoria. La prima categoria crede nell’uomo e nella visione che l’uomo abbia bisogno di storie. Indipendentemente da formati e catene di distribuzione, parlo di un bisogno primario. Ora il cammino che fa un racconto quando incontra la grande industria è paragonabile a quello di una cassata siciliana che deve essere spedita a Parigi. La si inscatola, sigilla e trasporta sperando che il suo sapore e la sua fragranza resistano a quel viaggio. Io credo che questa piccola rivoluzione del romanzo grafico sia partita dal basso. Dalla voglia di dire: “sì, c’è la possibilità di raccontare delle cose che non si sono ancora dette, il fumetto è un linguaggio giovane, ed è interessante seguire queste spinte”. Gli autori sentivano che era una pista percorribile perché avevano trovato dei lettori curiosi che confermavano loro questa sensazione. Lavorare con un media riprodotto è sempre un gioco di feedback, hai bisogno di sentire che esiste un’audience.
Oltre a essere un tributo ai grandi maestri, 5 è il numero perfetto rappresenta anche, secondo me, un momento di maturità espressiva. È come se le tue sperimentazioni visive e narrative avessero trovato in questo racconto un punto di equilibrio, che non corrisponde affatto ad un appiattimento stilistico.
Per me lo stile o la sperimentazione se sono separate dal raccontare non sono interessanti. Non sono un cultore della ricerca “ombelicale”, non cerco di parlare a me stesso. Mi piace in particolare l’uso dell’inchiostro, che si scioglie sulla tavola… Questa Napoli così intrisa di nero, così cupa e coinvolgente.
Tornando agli omaggi, nel racconto ho letto riferimenti a Chester Gould, a Muñoz & Sampayo, non ultimo a Pratt. È esatto?
Mi piacciono questi autori. Fatto salvo che, nel loro immenso lavoro, non hanno mai ambientato una sola storia a Napoli, non usano il montaggio come lo uso io e non hanno mai inteso veramente raccontare storie che contengano ironia, che per me è ossigeno essenziale.
Se potessi conversare attorno a un tavolo con i tre tuoi autori preferiti, viventi e non, chi sceglieresti? Immagino che siano di più, ma dovendo dolorosamente selezionare…
Parlo con i miei autori preferiti ogni giorno; anche oggi ho pranzato con Loustal. Ci si mostra le tavole e chiede consiglio. Si fa parte di una comunità. Ma come ho detto ritengo che sia necessario fare il punto. A quasi cinquant’anni suonati ti rivelerò una notizia sensazionale: il mio autore preferito sono io. Nel senso che lavoro su corde mie, che poi si sono formate seguendo e sedimentando le cose che ho amato, ma che fanno parte di una visione del mondo che si distilla disegno dopo disegno, parola dopo parola. La disciplina del narrare ti porta a cercare di riconoscere le cose intime tue, le cose che risuonano “vere”. Il postmoderno con la sua ginnastica citazionista, è morto, per fortuna. Salvo che per Tarantino. Ma lui è un talento formidabile e lo amiamo lo stesso. Ha cose da dire nel suo “viaggiare tra le merci”, (questo era il titolo del primo editoriale di “Frigidaire”, e parlo di 26 anni fa).
Situato da qualche parte in America del Sud, sospeso in un’ipotetica prima metà del Novecento, l’immaginifico Parador è il luogo nel quale ambienti, da anni, alcuni dei tuoi racconti. Nella sua vaghezza si è ormai radicato, in modo indissolubile, nella mente del tuo lettore. Torneremo ancora da quelle parti nelle prossime storie?
Ci sono già. Sto scrivendo un romanzo interamente ambientato in Parador, nel 1910, e pubblicato a puntate sul mio blog, si chiama Argento ed è quasi completato. E poi la storia lunga che sto disegnando ora, pubblicata in albi, Baobab, sempre 1910, ha una buona metà ambientata in Parador, per cui, sì, ci sto lavorando. Il Parador è in parte casa mia, ci abito spiritualmente.
Di te ho sempre ammirato oltre alla capacità autoriale la determinazione nel divulgare il lavoro dei tuoi colleghi, la volontà di “fare rete” che si è concretizzata nella Coconino Press che in appena sei anni ha pubblicato ben 180 romanzi grafici dei migliori autori in circolazione, italiani e non. Come ritieni si stia evolvendo questo mercato?
Ti ringrazio. Penso che il mercato si stia aprendo. La cosa determinante è che quelli tra di noi che vent’anni fa leggevano i fumetti si rendano conto che questa stagione è ricca quanto e più di quella di un tempo. Esistono veri e propri capolavori della narrazione a fumetti. Davvero grandi romanzi che vale la pena di leggere. “Up patriots to arms”, cantava quello.
Partiamo da questo assunto: il fumetto d’autore rappresenta una delle espressioni più alte della cultura pop. Quanto tempo ci vorrà ancora secondo te perché in Italia il fumetto sia sdoganato definitivamente dall’angusto ambito del genere di intrattenimento sub-culturale? Su quali leve a tuo parere occorre agire?
Ho letto un’interessantissima intervista a Vittorio Giardino, lui insiste sul fatto che in Italia la cultura sia essenzialmente cultura di parola. Per questo motivo autori riconosciuti a livello internazionale poi incontrano i signori che si occupano di letteratura e si sentono dire: “ma va? Esiste un lavoro così complesso nel fumetto?” E questo dice tutto. Io non credo che avrebbero il coraggio di domandarsi se esiste un lavoro così complesso nel teatro o nella letteratura, perché anche se non lo sapessero almeno si vergognerebbero. Invece noi siamo qui a sentire queste belle paroline, ad assistere con il sorrisetto sulle labbra a questi ingenui stupori.
Il fumetto risiede in una zona dove le forme di comunicazione si contaminano tra loro, e in questo è il suo fascino. Le tavole domenicali di Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay sono arte pura – altro non si può dire – creata per divertire i newyorchesi medi di inizio Novecento. Da un progetto commissionato e dalla sua ripetitività è nato qualcosa di unico, che ha anticipato il surrealismo e dato forma visiva alla psicanalisi che muoveva i primi passi, proprio allora. Coconino ha dato alle stampe nel 2005 un volume molto bello in occasione del centenario della pubblicazione della prima tavola di Little Nemo. Ci sono altre iniziative in programma per diffondere la conoscenza di uno degli autori più geniali del secolo scorso?
Guarda, ci sarebbe da fare una grande opera di pubblicazione di tutti i pionieri del periodo. Personalità della cultura grafica che hanno aperto al mondo un’idea, arte alta o bassa non esistono. Grosz, Dix, Feininger, Depero, Warhol, Steinberg o Picasso qui non hanno ancora insegnato nulla. Non vorrei apparire pessimista ma siamo a un secolo dalla rivoluzione cubista e ancora ci si sta chiedendo se il fumetto sia un linguaggio che può portare cultura. Ma allora siamo ancora al Salon dés refusée impressionista, solo che oggi almeno i libri si stampano e viaggiano da soli, di casa in casa, di testa in testa. Ci riempiono gli occhi e portano meravigliose prospettive esistenziali. Ma sì, mi piace questo essere gli ultimi della classe, trovo una certa aristocrazia nell’essere reietti. Dopotutto ciò che importa è che esistano i libri, le opere, e questo, sino a che non venga una rivoluzione malvagia come quella di Fahrenheit 451, è ancora garantito.